Il Gruppo Cooperativo Goel è una realtà nata nel 2003 nella zona della Locride e della Piana di Gioia di Tauro.
L’obiettivo del gruppo che raggruppa 9 cooperative sociali, 28 aziende agricole in Goel Bio, un’organizzazione di volontariato ed una fondazione è ripristinare la legalità in un territorio, come quello calabrese, vittima del potere mafioso.
Goel è attiva in diversi ambiti: dall’agroalimentare biologico al turismo sostenibile, passando per la moda etica ed i servizi sanitari. La cooperativa agisce per lo sviluppo del territorio, cercando di valorizzarne le tradizioni ed il capitale umano.
A tal proposito abbiamo sentito il presidente del Gruppo Cooperativo Goel, Vincenzo Linarello, che ci parla di cosa vuol dire fare impresa e fare cooperazione in Calabria e come è possibile creare una realtà virtuosa come quella della cooperativa calabrese.
Goel è un insieme di imprese e realtà, ma soprattutto è un soggetto che promuove dei valori, un forte contrasto alla ‘ndrangheta e al caporalato. Quanto è importante tutto questo e quanto si ripercuote quotidianamente sul lavoro di ciascun soggetto coinvolto in Goel, sui soci e quanto tutto questo si trasforma anche in un sentimento di appartenenza alla cooperativa?
È da un po’ di tempo che noi ci definiamo “una comunità di riscatto”, questa parola, quest’espressione che ci è molto cara ha, io dico di solito, un nome e un cognome: il nome è comunità e il cognome è riscatto. Comunità nel senso che Goel opera in settori molto diversi: sociale, sanitario, turismo, agroalimentare, tessile, moda e abbigliamento. Lo sforzo che stiamo facendo è fare in modo che ogni settore, ogni attività, ogni cooperativa, ogni società, si veda e si senta coinvolta all’interno di una comunità. Goel parte, si sviluppa e cresce sostanzialmente senza investimenti di privati e senza investimenti pubblici alle spalle, tranne rare eccezioni. Questo tipo di realtà non avrebbe potuto crescere se non dentro un forte mutualismo, intanto economico, perché questi settori si sono aiutati l’uno con l’altro nel momento in cui erano in difficoltà e dall’altro lato senza un senso di appartenenza forte che ha fatto in modo di fare quadrato quando ci sono state le aggressioni della ‘ndrangheta, delle massonerie deviate, quando ci sono stati mille ostacoli che in qualche modo intralciano il cammino di chi in Calabria vuole fare le cose per bene. Quindi la parte della comunità è sicuramente un aspetto importantissimo ma se ci si ferma la comunità può diventare anche una lobby. Il cognome, quindi è importantissimo, la comunità per che cosa? A quale fine? Solo per un mutuo aiuto reciproco? No. L’obiettivo è quello di creare percorsi di riscatto in Calabria. Percorsi di riscatto non solo per coloro che stanno dentro il sistema Goel, che ci lavorano, che hanno scommesso il loro futuro diretto ma anche per tutto il resto del territorio. Quindi creare una situazione di affrancamento dalla ‘ndrangheta, dalle massonerie deviate, dal clientelismo, dalla logica delle raccomandazioni, dall’iniquità di questo territorio. La finalizzazione è importante. Quindi, stiamo insieme, ci aiutiamo l’uno con l’altro, facciamo comunità perché siamo uniti in un progetto di riscatto unico.
Questo progetto di riscatto passa però anche per una grande capacità imprenditoriale che oggi sta avendo un grosso riscontro anche a livello internazionale grazie al vostro marchio Cangiari. Cangiari nasce anche dalla voglia di riscoprire delle tecniche, dei materiali e si sta affermando sempre di più proprio perché parte da dei valori territoriali e anche dal rispetto delle materie prime e anche delle persone che le utilizzano. Vorremmo capire qual è oggi lo stato dell’arte di Cangiari e quali novità ci aspettano da qui ai prossimi mesi?
Cangiari sta continuando. Con grande fatica perché è un’iniziativa che richiederebbe, in via ordinaria, dei grossi capitali di investimento, che noi non abbiamo. Però, malgrado ciò, sta andando avanti e sta diventando significativa anche dal punto di vista della tendenza di quello che il mercato ci rappresenta. Noi siamo il primo marchio di moda etica di fascia alta in Italia. Gli obiettivi imminenti del nostro ramo di Cangiari sono quelli, da un lato, di diversificare, quindi oltre che l’abbigliamento donna, siamo appena partiti con il progetto della “sposa etica” di Cangiari e nello stesso tempo anche con la capacità di aggregare esperienze di confezionamento tessile in difficoltà nel territorio per far fare del lavoro conto terzi. Da un lato questo rafforza la filiera produttiva interna e dall’altro crea possibilità di lavoro ad aziende che altrimenti non avrebbero grandi possibilità. L’altro orizzonte, oltre la diversificazione, è quello dell’internazionalizzazione, noi abbiamo bisogno di andare all’estero, abbiamo bisogno di andare in quei mercati dove essere etici ed ecologici è un reale vantaggio competitivo. È difficilissimo perché, ripeto, non abbiamo capitali adeguati per poter fare questi passaggi. Tuttavia il nostro più grande capitale, che è il capitale fiduciario contiamo che possa presto, in qualche modo, aiutarci a raggiungere questi obiettivi. Abbiamo anche in mente di sperimentare forme nuove di capitalizzazione nei prossimi mesi che riguarderanno tutto il gruppo e, quindi, anche lo sviluppo di Cangiari.
Sulla scia di questa voglia di ricerca e anche di innovare qualche mese fa avete presentato anche il progetto di “campus Goel”, un centro per la ricerca di eccellenze. Cosa è necessario per rendere questo centro sempre più forte e attrattivo e quali sono gli obiettivi che vi ponete di raggiungere nel breve periodo?
Intanto abbiamo raccolto tante idee e selezionato un gruppo di idee veramente eccezionali, a dimostrazione di come i calabresi hanno una capacità di innovazione e genialità che non ha veramente nulla da invidiare. Queste idee le stiamo accompagnando, quasi tutti vogliono, in qualche modo, aggregarsi al gruppo Goel. Goel sempre di più si candida quindi ad essere quasi un hub di idee etiche ed innovative in Calabria. Dall’altro lato vediamo che l’intuizione era giusta, cioè da un lato raccogliere, dare fiducia a chi aveva delle idee etiche ed innovative e dall’altro dotarlo di strumenti che consentano di poter sviluppare la propria idea senza dover pensare ad altri mille problemi come quelli amministrativi, di sviluppo, finanza, mercato, che sono le cose contro cui una piccola iniziativa, seppur geniale, si scontra e si infrange. Stiamo proseguendo questo percorso, certo, questo progetto ha ancora bisogno di aiuto perché possa diventare sostenibile solo con le idee che con la cantiera. Stiamo già vedendo, però, che l’intuizione era veramente azzeccata. Proseguiremo in questo senso, continueremo ad essere un punto di riferimento e, possibilmente, anche un collettore per i calabresi etici ed innovativi.
Parlando di prospettive, oggi abbiamo uno spaccato di Goel molto chiaro: abbiamo il successo di Cangiari nella moda, Goel Bio che sta iniziando ad essere una realtà sempre più importante sia per la trasformazione di alcuni prodotti, sia per la commercializzazione di altre specialità calabresi spesso sottovalutate. Possiamo sapere, in un’ottica di visione di questo gruppo, un sogno o un progetto su cui state già lavorando o che state immaginando adesso e sperate di veder realizzato da qui a cinque anni o a più lungo periodo?
Il malaffare spesso si giustifica, nei nostri territori, col fatto che è una dolorosa e necessaria realtà, “loro” dicono: se non ci fossimo noi a muovere un po’ di economia qui non ci sarebbe nulla. Assolutamente no! Ci sarebbe tanto di più e l’esatto opposto della ‘ndrangheta, cioè l’etica, se diventa vincente dimostra che è un grande imbroglio quello che sta dietro questo tentativo di legittimarsi da parte della ‘ndrangheta.
Noi attualmente miriamo a una crescita quantitativa, cioè dobbiamo rafforzare queste iniziative e farle diventare sempre più robuste, sia dal punto di vista dei risultati economici ma ancora di più dal punto di vista dei risultati occupazionali senza che questo faccia perdere minimamente la coerenza e la carica etica di queste iniziative. Questo ha un duplice valore: oltre, ovviamente, al fatto che crea economia, sviluppo e lavoro, vogliamo dimostrare, inequivocabilmente a tutti che l’etica, oltre che giusta, unita l’innovazione può diventare la chiave di volta della nostra terra. L’etica oggi ha bisogno di essere rilegittimata come un’alternativa seria e concreta per tutti. Non può essere solo un’alternativa per pochi eroi, che magari vengono applauditi, ammirati. Noi dobbiamo dimostrare che è una cosa su cui una regione come la Calabria, se ci punta, può veramente cambiare il suo futuro. Questo, capisci bene, che implica la delegittimazione del suo opposto. Il malaffare spesso si giustifica, nei nostri territori, col fatto che è una dolorosa e necessaria realtà, “loro” dicono: se non ci fossimo noi a muovere un po’ di economia qui non ci sarebbe nulla. Assolutamente no! Ci sarebbe tanto di più e l’esatto opposto della ‘ndrangheta, cioè l’etica, se diventa vincente, dimostra che è un grande imbroglio quello che sta dietro questo tentativo di legittimarsi da parte della ‘ndrangheta.
Parlando proprio di comunità e di supporto all’economia locale, qualche anno fa, precursori anche in questo, avete cercato di creare un esperimento, chiamandolo Aiutamundi, che era una sorta di circuito del credito parallelo, a metà tra una Banca del Tempo e un vero e proprio circuito parallelo come oggi può essere Sardex o come alcune piattaforme di sharing-economy che si stanno affermando. Dopo questi anni, e dopo quel tentativo, secondo te è arrivato il momento per la Calabria di sviluppare un modello di economia che faccia anche breccia su nuovi circuiti e dia anche più flessibilità alle nostre realtà, compresse nei canoni bancari sempre più asfissianti?
Se noi andiamo a vedere una zona come la Calabria vediamo uno dei più grandi paradossi dell’economia di mercato: da una parte c’è una marea di persone disoccupate e dall’altro c’è una marea di bisogni insoddisfatti. Teoricamente una grande domanda e una grande offerta. Tuttavia questa domanda e quest’offerta non si incontrano perché in mezzo non c’è la liquidità.
Io credo che il modello che noi abbiamo sviluppato, quello di Aiutamundi, sia un modello di grandissima efficacia, benchè la sperimentazione che noi abbiamo potuto condurre era una piccola sperimentazione. La nostra era un’attività di sviluppo di un modello più che una vera e propria sperimentazione. Tuttavia noi siamo riusciti a creare qualcosa di unico: la possibilità di avere una moneta alternativa senza avere una moneta alternativa. Il sistema di Aiutamundi fa a meno del denaro contante e utilizza l’Euro, non è una “divisa” diversa dall’Euro. È perfettamente integrata nella normativa fiscale e giuslavoristica nazionale. Noi la stiamo proponendo ma abbiamo bisogno di qualcuno con le spalle molto più forti delle nostre perché la possa lanciare e possa creare un’adesione di una massa critica tale da rendere il sistema perfettamente usabile e sostenibile. Siamo convinti che questa sia la strada giusta perché oggi ci sono delle storture che il mercato crea. Se noi andiamo a vedere una zona come la Calabria vediamo uno dei più grandi paradossi dell’economia di mercato: da una parte c’è una marea di persone disoccupate e dall’altro c’è una marea di bisogni insoddisfatti. Teoricamente una grande domanda e una grande offerta. Tuttavia questa domanda e quest’offerta non si incontrano perché in mezzo non c’è la liquidità. Questa è una stortura evidente del mercato. In attesa di trovare delle soluzioni più strutturali un’iniziativa come quella di Aiutamundi diventa un correttore, un correttivo di grande efficacia di questa stortura.
Vorrei chiudere con un’ultima domanda: un consiglio da un imprenditore come Vincenzo Linarello a chi oggi vuole fare cooperazione in Calabria e magari abita in zone rurali e vede poche opportunità. Un consiglio pratico ed uno per quanto riguarda la filosofia con cui si deve collaborare e cooperare per far crescere un territorio.
Io riassumerei tutto in due cose. La prima è non stare da soli, stare insieme. In Calabria non si va da nessuna parte da soli. Quindi da un lato aggregarsi, dall’altro bisogna essere i migliori, in Calabria non ci sono vie di mezzo. In qualunque ambito uno vuole andare a cimentarsi se ci si accontenta di competenze mediocri non si va da nessuna parte, per qualunque professione, qualunque lavoro, qualunque cosa si voglia fare. Quindi aggregarsi ed essere i migliori ed ovviamente poi fare delle scelte chiare. Io dico che o si è veramente etici o essere un po’ etici, in questa terra, non è una scelta vincente.

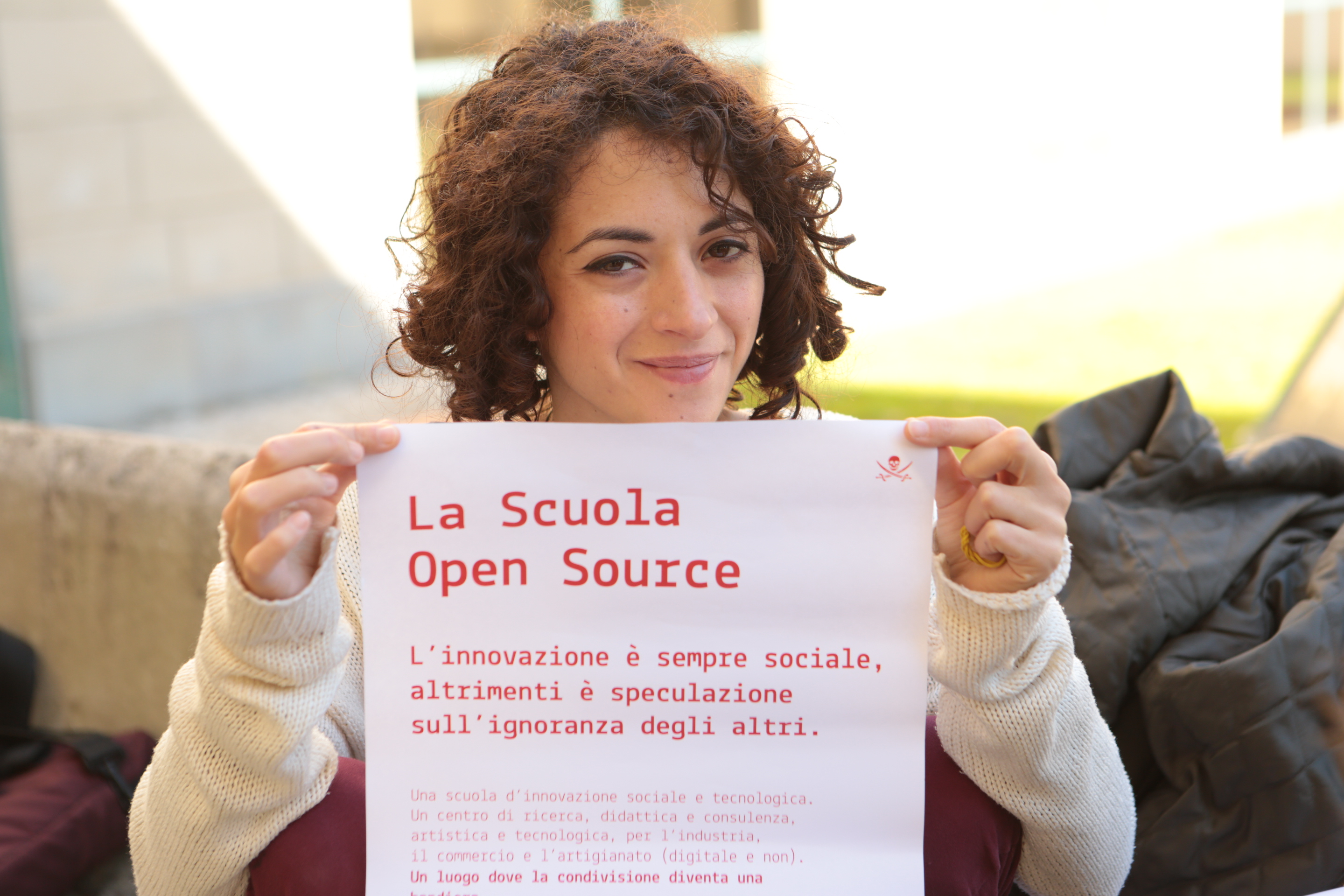





 la prima espressione di moneta senza Stato. Ma dato che in rete abbiamo a che fare con anonimi, come possiamo essere sicuri che non stiano provando a truffarci?
la prima espressione di moneta senza Stato. Ma dato che in rete abbiamo a che fare con anonimi, come possiamo essere sicuri che non stiano provando a truffarci?


 sperimentali urbani fino alla manutenzione, quindi la potatura e la valutazione della stabilità. Infine ci occupiamo anche della formazione degli operatori che vanno ad occuparsi della manutenzione del verde.
sperimentali urbani fino alla manutenzione, quindi la potatura e la valutazione della stabilità. Infine ci occupiamo anche della formazione degli operatori che vanno ad occuparsi della manutenzione del verde.
 Con la legge regionale n. 11 del 2003 la Regione Calabria ha costituito nuovi consorzi gestiti dalle rappresentanze agricole, trasferendo a queste ultime, insieme alla gestione, anche i debiti contratti fino a quel momento.
Con la legge regionale n. 11 del 2003 la Regione Calabria ha costituito nuovi consorzi gestiti dalle rappresentanze agricole, trasferendo a queste ultime, insieme alla gestione, anche i debiti contratti fino a quel momento.
 L’arroganza del potere arriva al culmine quando, all’indomani dell’insediamento di Bilotta, nominato dal centrodestra che allora governava la Regione, si riaprì all’improvviso la partita del debito; lo stesso commissario dichiarò che il debito era almeno di 156 mln di euro, non più di 36 mln.
L’arroganza del potere arriva al culmine quando, all’indomani dell’insediamento di Bilotta, nominato dal centrodestra che allora governava la Regione, si riaprì all’improvviso la partita del debito; lo stesso commissario dichiarò che il debito era almeno di 156 mln di euro, non più di 36 mln. senza la certezza dell’articolo 23, sono certo che avrebbero l’opinione pubblica a favore;
senza la certezza dell’articolo 23, sono certo che avrebbero l’opinione pubblica a favore; La seconda amara considerazione è che anche gli organismi intermedi non battono colpi da diverso tempo. Quelli che dovrebbero filtrare le istanze dei cittadini e delle categorie verso la politica, il sale della democrazia. Invece, producono tutti i giorni solo convegni per interrogarsi sulle ricette per lo sviluppo.
La seconda amara considerazione è che anche gli organismi intermedi non battono colpi da diverso tempo. Quelli che dovrebbero filtrare le istanze dei cittadini e delle categorie verso la politica, il sale della democrazia. Invece, producono tutti i giorni solo convegni per interrogarsi sulle ricette per lo sviluppo.