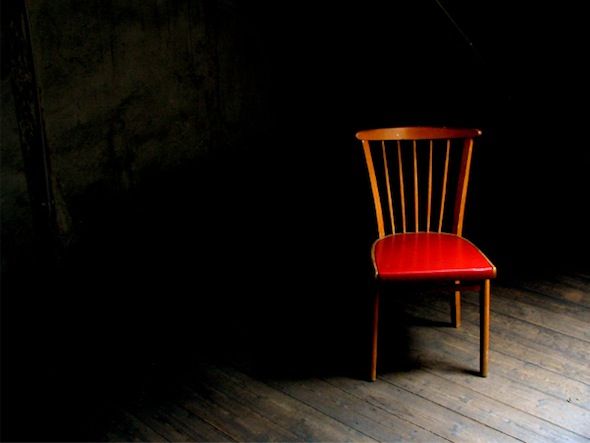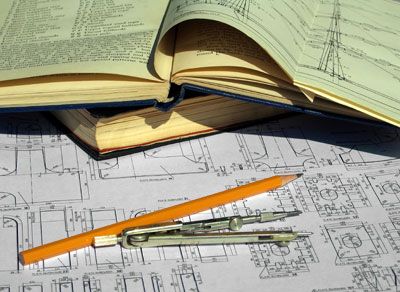Cosa accade nel momento in cui un atto processuale non è notificato personalmente dall’Ufficiale Giudiziario ma “a mezzo posta”, e l’avviso di ricevimento non risulta correttamente sottoscritto o – addirittura – è privo di alcuna sottoscrizione? Secondo la Cassazione la notifica è comunque efficace.

La notifica a mezzo del servizio postale è disciplinata dall’art. 149 c.p.c. e dalla l. 890/82: in questi casi l’Ufficiale Giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’Ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento, il quale è poi spedito all’indirizzo predisposto dall’Ufficiale. L’avviso di ricevimento «costituisce prova dell’eseguita notificazione».
Secondo la Suprema Corte «l’avviso di ricevimento, che è parte integrante della relata di notifica, riveste natura di atto pubblico», e in quanto gode della fede privilegiata prevista dall’art. 2700 c.c. , di modo che per quanto attiene alla “forza certificatoria” la notificazione effettuata dall’agente postale è equiparata in tutto e per tutto a quella posta in essere dall’Ufficiale Giudiziario, sino – ovviamente – a querela di falso.
La giurisprudenza ha addirittura ritenuto del tutto valida la notifica di un atto in cui fosse del tutto illeggibile la firma del destinatario, senza nemmeno l’indicazione della qualità del consegnatario e senza che fosse barrata la relativa casella tra quelle predisposte dal modello di avviso di ricevimento: in questi casi «deve ritenersi che la sottoscrizione illeggibile, apposta nello spazio riservato alla firma del ricevente, sia stata vergata dallo stesso destinatario» .
Categoria: Legale
-
-
L’amministratore di condominio può partecipare alla mediazione soltanto se espressamente autorizzato dall’assemblea dei condomini.

E’ questa la soluzione adottata dalle più recenti disposizioni di legge; vediamo perché: con il d.l. 69/13 è stata reintrodotta l’obbligatorietà della media conciliazione, ma solo per determinate materie. Tra queste certamente rilevante è quella condominiale, dato che il contenzioso che ne deriva affolla gran parte dei tribunali italiani. Ricordiamo che l’istituto in esame è previsto espressamente a pena di improcedibilità: in altre parole, ogni qual volta il condominio vorrà agire (con esclusione delle procedure volte al recupero dei crediti relativi ad oneri condominiali) o dovrà resistere in giudizio, si dovrà preliminarmente utilizzare la procedura di mediazione di cui al D.Lgs. 28/10 . Ci si chiede, allora, se l’amministratore del condominio possa o meno partecipare alla media conciliazione impegnando formalmente il condominio di cui ha, di norma, la rappresentanza legale.
La risposta ci viene fornita dal nuovo art. 71 quater, delle disp. att. c.c. : «Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice. Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione».
Dal tenore letterale della norma appena citata appare evidente che in mancanza di apposita deliberazione assembleare l’amministratore non è legittimato a partecipare alla procedura di mediazione, la quale non potrà che concludersi con una dichiarazione negativa per assenza della parte convocata. Ne deriva, inoltre, che nell’ipotesi di specie potranno essere irrogate la sanzione processuale di cui all’art. 8, co. 5, del citato D.Lgs. 28/10, secondo cui «Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio».
-
In una cooperativa il perseguimento dello scopo mutualistico, ovvero la realizzazione di un servizio al fine di garantire un vantaggio ai soci, è un obbligo talmente essenziale e pregnante da mettere a rischio, nelle ipotesi in cui venga trascurato, la vita stessa della società.
Secondo l’art. 2545 c.c. gli amministratori ed i sindaci hanno l’obbligo di indicare, nelle rispettive relazioni, i criteri utilizzati nella gestione per il conseguimento dello scopo mutualistico; in caso contrario la cooperativa rischia la revoca degli amministratori e dei sindaci e l’affidamento ad un commissario , o addirittura – nelle ipotesi più gravi – lo scioglimento della società . Una disciplina particolarmente severa, ma giustificata dall’essere inserita in un quadro normativo, anche a copertura costituzionale, in cui al fenomeno della cooperazione si riconosce una spiccata funzione sociale, con conseguenti agevolazioni e vantaggi. Coerentemente, anche la legislazione speciale (D.lgs. n. 220/02, art. 12) prevede che in sede di vigilanza il Ministero possa disporre la cancellazione dall’apposito albo nazionale per gli enti cooperativi “che si sottraggono all’attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche”.
-
Chi è il responsabile dei danni subiti da un alunno durante l’orario scolastico?
La risposta ci viene fornita da una recente decisione della Suprema Corte (sentenza n. 22752 del 4 ottobre 2013), la quale, ribadendo un indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato, ha affermato che l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, «determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della medesima l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni».
Sulla scuole vige l’obbligo di predisporre tutti gli accorgimenti necessari atti a che l’alunno posso subire dei danni ma anche affinchè non provochi danni a se stesso. Tale obbligo ha una portata oggettiva molto amplia, se solo si pensa che viene anche all’esterno dell’edificio scolastico, compreso il cortile antistante l’edificio rientrante però nella disponibilità della scuola.
L’obbligo di vigilanza dell’istituto scolastico, inoltre, è anche commisurato – oltre che alla diligenza richiesta dalla particolare natura delle cose – anche alle circostanze del caso concreto, quali, ad esempio, l’organizzazione interna adottata anche al fine di rispettare l’obbligo di protezione del minore. Ne consegue un regime probatorio più agevole per l’attore, il quale «deve provare che tale danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre l’istituto ha l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa a sé non imputabile». Ricordiamo che la giurisprudenza ha precisato che il contenuto del dovere di sorveglianza va determinato in modo relativo, con riferimento all’età e al grado di maturità del soggetto sottoposto, e va esteso a tutto l’ambiente che lo circonda. Il dovere di vigilanza inizia quando i genitori affidano il minore all’istituto o all’insegnante e termina quando il figlio passa in custodia di nuovo ai genitori.
-
Nell’ordinamento delle società cooperative vige un generale principio di parità di trattamento dei soci ad opera della società, cui gli amministratori devono obbligatoriamente uniformarsi: è questo un caposaldo contenuto oggi contenuto nell’art. 2516 c.c., per come novellato dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ma anche in passato considerato cardine del sistema normativo disciplinante la cooperazione.
Secondo la Cassazione, infatti, un obbligo così pregnante è dovuto sia alla più accentuata rilevanza dell’elemento personale che è propria delle cooperative, e che si esprime anche nelle limitazioni alla possibilità per ciascun socio di possedere oltre un certo numero di azioni, sia alla connessa regola del voto capitario in assemblea, “sia per la connotazione solidaristica di queste forme societarie, cui la stessa mutualità storicamente si riallaccia” (sentenza n. 6510/04)
Secondo la Suprema Corte tale obbligo è una manifestazione del più ampio principio di buona fede, caratterizzante ogni rapporto contrattuale: ne deriva che è più che giustificato che “gli aderenti ad una cooperativa si attendano, a parità di apporti, la possibilità di godere di pari benefici e quindi di fruire in pari misura dei servizi mutualistici che la società è chiamata a rendere loro”.
Il principio di parità di trattamento, quindi, stabilisce una regola di comportamento cui gli organi sociali debbono scrupolosamente attenersi, la cui violazione, così come nel caso esaminato dalla S.C., comporta una responsabilità degli amministratori, con conseguente risarcimento del danno, di cui all’art. 2395 c.c.
La parità di trattamento, ovviamente, non costituisce una regola assoluta, ma subisce varie gradazioni, così come ogni principio giuridico, in base alle concrete circostanze di fatto: ad esempio sarà legittima, in una cooperativa di lavoro, una differente retribuzione tra i soci purché dovuta alle diverse ed oggettive professionalità proprie dei vari soci lavoratori.
-
Anche lo scopo mutualistico può essere graduato, o meglio, può esserlo la sua intensità: questo, infatti, grazie ad una interpretazione ampia dell’art. 45 Cost. viene inteso non nell’esigenza che tutta l’attività sia svolta dai soci cooperatori ma soltanto “prevalentemente” da questi.
Una tesi confermata dall’art. 2512 c.c., secondo il quale le cooperative a mutualità prevalente “svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci”, ma anche dall’art. 2521 c.c., secondo il quale l’atto costitutivo, che stabilisce le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica, “può prevedere che la società svolga la propria attività anche nei confronti dei terzi”. E’ quindi prevalso un orientamento per il quale la cooperativa non debba rivolgersi esclusivamente ai propri soci o, detto in altri termini, lo svolgimento dello scopo mutualistico non debba svolgersi solamente con e per i soci; al contrario, esso può rivolgersi anche a soggetti terzi, in quanto la possibilità di cedere beni e servizi a non soci, conciliando così il fine mutualistico con una attività commerciale a fini di lucro, certamente può comportare vantaggi patrimoniali alla società.
In tale ultimo caso – massimamente prevalente nella prassi – sarà fondamentale l’esplicito inserimento nell’atto costitutivo della previsione di cui all’art. 2521 c. 2 c.c., secondo il quale “L’atto costitutivo … può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi”, la cui omissione preclude alla cooperativa la possibilità di instaurare rapporti con soggetti diversi dai soci. Il riferimento è, ovviamente, ai rapporti contrattuali “tipici” dell’attività della società, ovvero quei rapporti instaurati di norma con i soci per il perseguimento dello scopo mutualistico, e non ai rapporti strumentali, necessari solo ai fini dello svolgimento dell’attività sociale.
-
Il periodo di servizio svolto durante la vigenza del contratto di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio, anche in quelle ipotesi in cui questa sia presa in considerazione da discipline che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva, come quella sugli scatti di anzianità.
E’ questo il principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 20074/10, con la quale la S.C. ha dovuto valutare la legittimità della norma di CCNL del settore autoferrotranvieri nella parte in cui impediva al lavoratore, il cui contratto di formazione e lavoro fosse stato trasformato in contratto a tempo indeterminato, di beneficiare di aumenti periodici di anzianità, computando anche l’anzianità di servizio maturata nel periodo del contratto di formazione e lavoro.
Poiché il D.L. n. 726 del 1984, all’art. 3 dispone che “il periodo di formazione è computato nell’anzianità di servizio”, il problema che si è posto in giurisprudenza è stato quello di stabilire se alla contrattazione collettiva fosse, o meno, consentito di operare tale modifica (peggiorativa) del disposto legislativo.
Le Sezioni Unite sono quindi intervenute per superare il precedente contrasto giurisprudenziale, stabilendo che “l’equiparazione posta dalla legge (periodo di formazione e lavoro = periodo di lavoro ordinario), in quanto formulata in termini generali ed assoluti, non è derogabile dalla contrattazione collettiva”. L’equiparazione tra periodo di formazione ed anzianità di servizio esprime quindi un generale canone che si sovrappone, per il suo carattere inderogabile, anche alla contrattazione collettiva, la quale può sì disciplinare nel modo più vario istituti contrattuali rimessi interamente alla sua regolamentazione, come gli scatti di anzianità, ma non potrebbe introdurre un trattamento in senso lato discriminatorio in danno dei lavoratori che abbiano avuto un pregresso periodo di formazione.
-
I benefici fiscali concessi alle cooperative sono revocabili anche senza il parere del Ministero del lavoro, se sussistono indizi che la veste mutualistica è una copertura finalizzata a versare meno tasse.
Secondo la Cassazione (sentenza n. 15217/12), in tema di agevolazioni tributarie per la cooperazione, il procedimento di verifica dei «presupposti di applicabilità» di cui all’art. 14, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, che prevede come obbligatorio il preventivo parere degli organi di vigilanza, “attiene ai soli requisiti soggettivi dell’ente, ma non riguarda le condizioni, stabilite dal precedente art. 10, relative alla natura e alle modalità di svolgimento della sua attività produttiva, di modo che, sotto questo profilo, nessun limite incontra l’ordinario potere di accertamento spettante all’amministrazione finanziaria, la cui attività, al riguardo, va ritenuta legittima, indipendentemente dall’esistenza o meno del suddetto parere”.
Nel caso di specie l’accertamento aveva avuto ad oggetto una maggiore imposta dovuta dal contribuente (prima Associazione di produttori agricoli, poi diventata cooperativa), in considerazione del fatto che era emerso che l’Associazione non aveva rispettato le finalità istituzionali, sia perchè la maggior parte dei soci non conferiva il prodotto, sia perché l’Associazione si riforniva da terzi ben oltre la misura ammessa. La S.C., ha quindi richiamato pregressi e consolidati orientamenti giurisprudenziali, secondo cui in tema di agevolazioni tributarie in favore delle società cooperative la conformità degli statuti ai principi legislativi in materia di mutualità comporta solamente una presunzione di spettanza delle agevolazioni o esenzioni tributarie: tale presunzione è relativa e non impedisce all’Amministrazione finanziaria di disconoscere, per ogni singolo periodo di imposta, le agevolazioni suddette, semprechè fondi il suo accertamento su dati concreti, a nulla rilevando l’eventuale parere del Ministero del lavoro favorevole alla cooperativa.
In applicazione di tali principi la S.C., non avendo la cooperativa dimostrato l’esistenza dei presupposti di fatto legittimanti le agevolazioni fiscali, ha rigettato il ricorso, accertando quindi che l’asserita veste mutualistica fungeva, in realtà, da copertura ad una normale attività di impresa.
-
L’Albo Nazionale delle Società Cooperative è stato istituito con il D.M. 23 Giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico), e sostituisce i registri prefettizi e lo schedario generale della cooperazione; è tenuto dallo stesso Ministero e gestito con modalità telematiche dalle Camere di commercio.
L’Albo si compone di due sezioni, differenziate in base alla natura della cooperativa che chiede l’iscrizione:
- la prima sezione è riservata alle società cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile; nell’ambito di questa sezione è stata creata un ulteriore sezione per le cooperative a mutualità prevalente di diritto, come ad esempio le cooperative sociali, qualificate in tal modo direttamente dalla legge.
- nella seconda devono iscriversi le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.
Il Ministero con la circolare attuativa del 6.12.2004 ha puntualmente previsto e disciplinato l’iter di iscrizione, obbligatoria per tutte le cooperative ai fini anagrafici nonché necessaria, per le cooperative a mutualità prevalente, quale presupposto per la fruizione delle agevolazioni di natura fiscale previste dall’art. 223 duodecies, comma 6, C.C.
Nella domanda di iscrizione la società cooperativa dovrà indicare inoltre l’appartenenza ad una delle categorie previste dall’art. 4 del decreto istitutivo, ovvero:
- cooperative di produzione e lavoro;
- cooperative di lavoro agricolo;
- cooperative sociali;
- cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento;
- cooperative edilizie di abitazione;
- cooperative della pesca;
- cooperative di consumo;
- cooperative di dettaglianti; cooperative di trasporto;
- consorzi cooperativi;
- consorzi agrari;
- banche di credito cooperativo;
- consorzi e cooperative di garanzia e fidi;
- altre cooperative.
Secondo il tenore letterale della nuova formulazione dell’art. 2511 del Codice Civile, introdotta dalla l. 99/09, secondo cui “Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l’Albo delle società cooperative di cui all’art. 2512, c. 2 del C. C. e all’art. 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del Codice Civile”, sembra che l’iscrizione all’Albo delle società cooperative abbia efficacia costitutiva della società cooperativa.
-
La contumacia, ovvero la mancata costituzione in giudizio non esclude la soccombenza e, quindi, la conseguente condanna alle spese di lite: è questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza 373/15, con la quale la S.C. ha cassato una sentenza del Tribunale di Roma, quale giudice d’appello, il quale aveva respinto l’impugnazione proposta contro la sentenza del Giudice di Pace che, accogliendo il ricorso del contribuente avverso cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative in materia tributaria irrogate dalla Prefettura, aveva tuttavia compensato tra le parti le spese di causa. Il Tribunale, infatti, giustificava la compensazione a causa dell’assenza di costituzione e, quindi, di contestazione, dell’Ente convenuto, attribuendo a tale comportamento omissivo il valore di adesione alle ragioni del ricorrente.
Parte ricorrente, a sostegno della propria tesi, sosteneva che un comportamento neutro (la mancata costituzione) non implica esclusione di dissenso rispetto alle ragioni di parte avversa, gravando in tal modo il cittadino dei costi dell’inefficienza della p.a., così in palese violazione del diritto di difesa tutelato da copertura costituzionale.
La Cassazione, accogliendo il ricorso e richiamando cospicua giurisprudenza sul punto, ha sostenuto che “Non può avere perciò rilievo alcuno, ai fini dell’applicazione della disciplina fissata nell’art. 92 c.p.c., la circostanza che la parte che ha dato causa al processo abbia poi omesso di costituirsi in esso e comunque di dispiegare attività difensiva, condotta alla quale va attribuita valenza totalmente neutra siccome inidonea a costituire indice di esclusione del dissenso e addirittura di adesione all’avversa richiesta (in termini anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4485 del 28/03/2001), e che anzi può semmai considerarsi espressione di mera indifferenza rispetto alle ragioni di economia che dovrebbero indurre le parti (specie quelle pubbliche) all’adozione di ogni cautela utile ad evitare inutili dispendi di energia processuale”.
-
In una società moderna ed in continua evoluzione l’accertamento delle responsabilità penali è sempre più legato a valutazioni tecniche che non possono prescindere da specifiche e puntuali competenze settoriali: da qui la sempre maggiore rilevanza della figura del consulente tecnico del Pubblico Ministero, il quale ai sensi dell’art. 359 c.p.p. “quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera”.
Il P.M nomina il consulente tecnico scegliendo di regola una persona iscritta negli albi dei periti, e “Per la liquidazione del compenso al consulente tecnico si osservano le disposizioni previste per il perito” (Art. 73 disp. att. c.p.p, c. 1): l’art. 232 c.p.p., infine, rimanda alle leggi speciali la quantificazione del compenso.
La legge speciale che trova qui applicazione è notoriamente il D.P.R. 30.05.2002 n° 115 (Testo unico in materia di spese di giustizia), secondo cui:
- Art. 49 (Elenco delle spettanze):
- Agli ausiliari del magistrato spettano l’onorario, l’indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico.
- Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.
- Art. 50 (Misura degli onorari):
- La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell’incarico.
- Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l’urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l’eventuale superamento di tale limite per attività alla presenza dell’autorità giudiziaria.
- Art. 55 (Indennità e spese di viaggio):
- Per l’indennità di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali. L’incaricato è equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E’ fatta salva l’eventuale maggiore indennità spettante all’incaricato dipendente pubblico.
- Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei.
- Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato.
Le tabelle indicate sono contenute nel D.M. 182/02, secondo il cui allegato, all’art. 1:
Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell’accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non e’ possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell’incarico e sono determinati in base alle vacazioni. Segue, quindi, l’indicazione di determinate tipologie di perizie (ad es. perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale; in materia di bilancio e relativo conto dei profili e perdite; in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, etc) per le quali sono stabiliti compensi che variano in base allo scaglione di riferimento.
Le vacazioni, invece, in passato erano disciplinate dalla l. 319/80 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria), il cui art. 4 (Onorari commisurati al tempo) recita:
- Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l’articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni.
- La vacazione è di due ore. L’onorario per la prima vacazione è di L. 10.000 e per ciascuna delle successive è di L. 5.000.
- L’onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.
- L’onorario per la vacazione non si divide che per metà; trascorsa un’ora e un quarto è dovuto interamente.
- Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.
- Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell’autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni.
- Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l’espletamento dell’incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione”.
I valori delle vacazioni sono stati rideterminati del D.M. 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale), il cui articolo 1 stabilisce che:
“Gli onorari di cui all’art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive”.
-
Il nuovo Ddl concorrenza ha lasciato inalterata la disciplina di molti settori professionali, uno di questi è sicuramente quello farmaceutico.
Altri ambiti, invece, hanno subito sostanziali modifiche che rischiano di cambiare l’intero sistema.
Il settore notarile è quello che ha vissuto maggiori cambiamenti.
I notai vengono spesso riconosciuti come una categoria piena di prerogative e privilegi.
Già il governo Monti aveva cercato di liberalizzare questo ambito professionale, eliminando le tariffe ed ampliando il territorio di competenza. Il nuovo esecutivo è intervenuto ulteriormente sul settore attuando un’effettiva (?) liberalizzazione.
Il nuovo esecutivo è intervenuto ulteriormente sul settore attuando un’effettiva (?) liberalizzazione.
Il provvedimento più rilevante riguarda la stipulazione dei contratti immobiliari non abitativi dal valore catastale inferiore i 100mila euro. Si tratta in sostanza di locali o capannoni ad uso commerciale.
Con la nuova normativa i privati potranno rivolgersi non solo ai notai, anche a degli avvocati o ad altri professionisti.
Viene meno in questo modo una prerogativa esclusiva del mondo notarile. Esso, però, denuncia alcuni problemi relativi alla competenza di chi andrà svolgere questi atti e ai relativi sistemi di sicurezza.Come riportato dal Corriere della Sera, la categoria professionale in questione ritiene che il sistema italiano notarile sia estremamente efficiente ed invidiato da tutto il mondo.
In Italia tutti gli atti notarili che contemplino la stipulazione di un contratto immobiliare non locativo vengonp registrati nei pubblici registri. C’è, dunque, un controllo molto stretto da parte del Ministero della Giustizia, che evita così pericolose infiltrazioni da parte di associazioni a delinquere come la criminalità organizzata.
Con il nuovo ddl concorrenza si viene a creare, invece un sistema misto, a metà tra il modello italiano e quello nord-americano, dove non esistono affatto i pubblici registri.
Secondo Mario Notari, notaio e docente dell’Università Bocconi, interpellato dal Corriere della Sera, inserire all’interno del sistema atti non sottoposti al controllo pubblico rischia di alimentare fenomeni quali il riciclaggio e le infiltrazioni mafiose. Il settore edilizio-commerciale è molto delicato da questo punto di vista.
Una maggiore demarcazione delle competenze e un’estensione dei controlli pubblici a tutti i tipi di atti renderebbe di sicuro la liberalizzazione enormemente più efficiente rispetto a quella paventata in questi giorni.