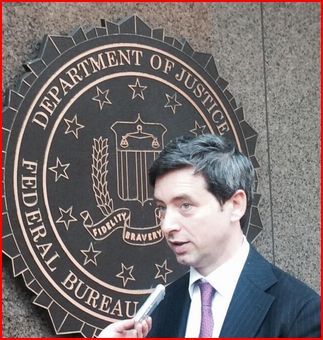Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), ma con la significativa esclusione del solo articolo 18 (tutela reale e, quindi, diritto alla reintegra in caso di licenziamento illegittimo) ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo.
Tale prescrizione è prevista dall’art. 2 della l. 142/01, disciplinante le cooperative di lavoro, volto a garantire ai soci lavoratori una parità di diritti rispetto ai lavoratori propriamente subordinati, o comunque un complesso di tutele minime ed inderogabili, ma con la contestuale previsione di un rapporto di consequenzialità fra l’esclusione del socio ed il recesso, incidendo la delibera di esclusione pure sul concorrente rapporto di lavoro.
 Secondo l’intendo del legislatore, l’esclusione della tutela reale opera in ogni caso in cui insieme al rapporto di lavoro venga a cessare anche il rapporto associativo, al fine di evitare per le società cooperative, considerata l’evidente rilevanza dell’intuitus personae, la possibilità di reintegrazione del socio lavoratore e quindi di ricostituzione in via autoritativa del rapporto societario.
Secondo l’intendo del legislatore, l’esclusione della tutela reale opera in ogni caso in cui insieme al rapporto di lavoro venga a cessare anche il rapporto associativo, al fine di evitare per le società cooperative, considerata l’evidente rilevanza dell’intuitus personae, la possibilità di reintegrazione del socio lavoratore e quindi di ricostituzione in via autoritativa del rapporto societario.
Tale principio, nella sua eccezione, è stato di recente ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 11548/15, con la quale la Suprema Corte ha stabilito il diritto alla reintegra di un socio-lavoratore, con conseguente applicabilità dell’art. 18 Stat. Lav., in quanto nell’ipotesi all’attenzione degli ermellini la delibera di esclusione del socio era già stata dichiarata nulla dal giudice di secondo grado e non impugnata davanti al giudice delle leggi. In assenza di un legittimo provvedimento di esclusione del socio (l’annullamento del recesso era oramai passato in giudicato), ha quindi trovato spazio l’ipotesi altrimenti residuale di cui all’art. 18 Stat. Lav.