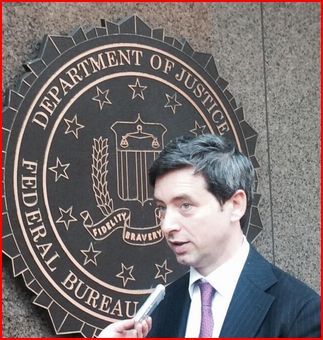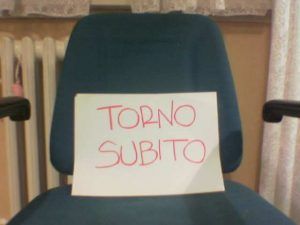La Camera dei Deputati ha approvato nella serata di ieri il nuovo provvedimento sulla responsabilità civile dei magistrati.
Si tratta di una misura politica destinata a far discutere, ma resasi necessaria dopo che nel 2011 la Corte di Giustizia europea ha condannato il nostro paese per violazione degli obblighi di adeguamento del diritto interno alle norme comunitarie.
L’Italia ha dovuto così riformare un sistema in vigore da più di 27 anni.
 La nuova legge cambia in maniera decisiva la disciplina di questa fattispecie delicata.
La nuova legge cambia in maniera decisiva la disciplina di questa fattispecie delicata.
La magistratura sarà sottoposta ad un tipo di responsabilità civile indiretta. I cittadini potranno rivalersi sui giudici solamente per il tramite dello Stato: dovranno cioè presentare un’istanza di risarcimento danni per dopo o colpa grave del magistrato davanti al presidente del Consiglio; sarà quest’ultimo, una volta liquidato il risarcimento, a doversi rivalere sul giudice colpevole.
Cambia anche la somma da pagare che avrà un ammontare massimo della metà dello stipendio annuo del magistrato, mentre la legge precedente poneva il tetto limite ad un terzo del compenso.
In generale cosa altro cambia rispetto alla precedente normativa?
L’aspetto che viene maggiormente contestato dal Csm è l’eliminazione del filtro di ammissibilità del ricorso.
Fino alla modifica di questi giorni, il tribunale distrettuale doveva promuovere una deliberazione preliminare di ammissibilità del ricorso. Questo tipo di filtro ha portato a soli 7 ricorsi vinti dai cittadini su oltre 400 dichiarati ammessi.
Il timore del Csm è che si possano moltiplicare le richieste di risarcimento danni, limitando così l’autonomia degli organi giurisdizionali. Sul punto il ministro della Giustizia Orlando si è dichiarato disposto al dialogo e a modificare alcune questioni problematiche.
Le novità, però, non si fermano all’eliminazione del filtro del tribunale distrettuale. Ci sono anche sostanziali allargamenti dal campo di applicazione.
Innanzitutto viene ridefinito il concetto di colpa grave del magistrato che riguarderà anche i casi di travisamento del fatto e delle prove.
In generale la colpa grave interessa tutte le violazioni palesi della legge italiana ed europea, le dichiarazioni di esistenza di un fatto palesemente rinnegati dagli atti processuali o l’emissione di provvedimenti di custodia cautelare personale o reale fuori dai casi previsti dalla legge o semplicemente immotivati.
Con la la nuova legge, dunque, il cittadino potrà chiedere il risarcimento danni anche se non è stato oggetto di provvedimenti restrittivi della propria libertà personale.
L’ultimo cambiamento sostanziale riguarda, invece, i termini entro i quali si può presentare il ricorso, che passano da 24 a 36 mesi.